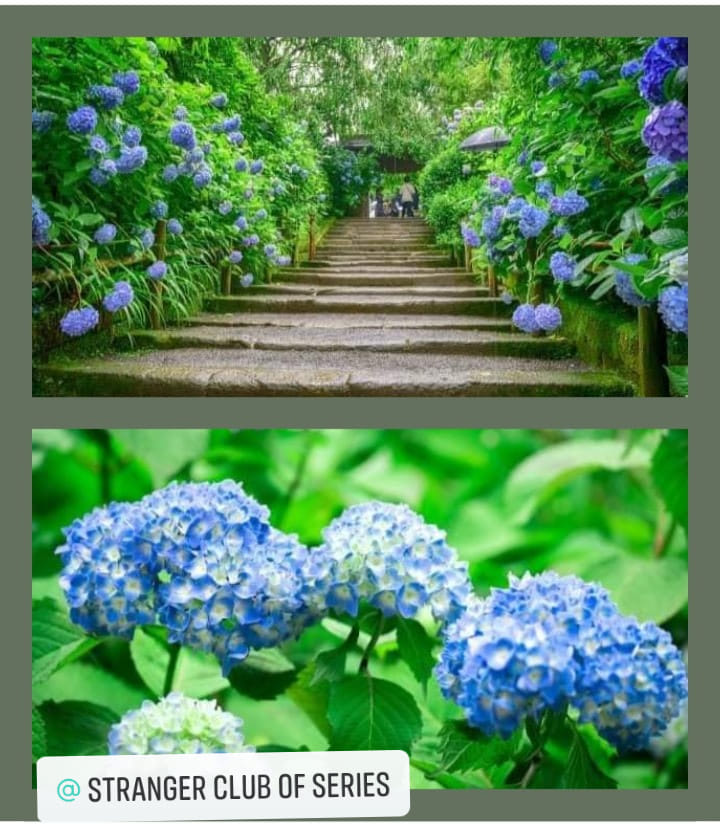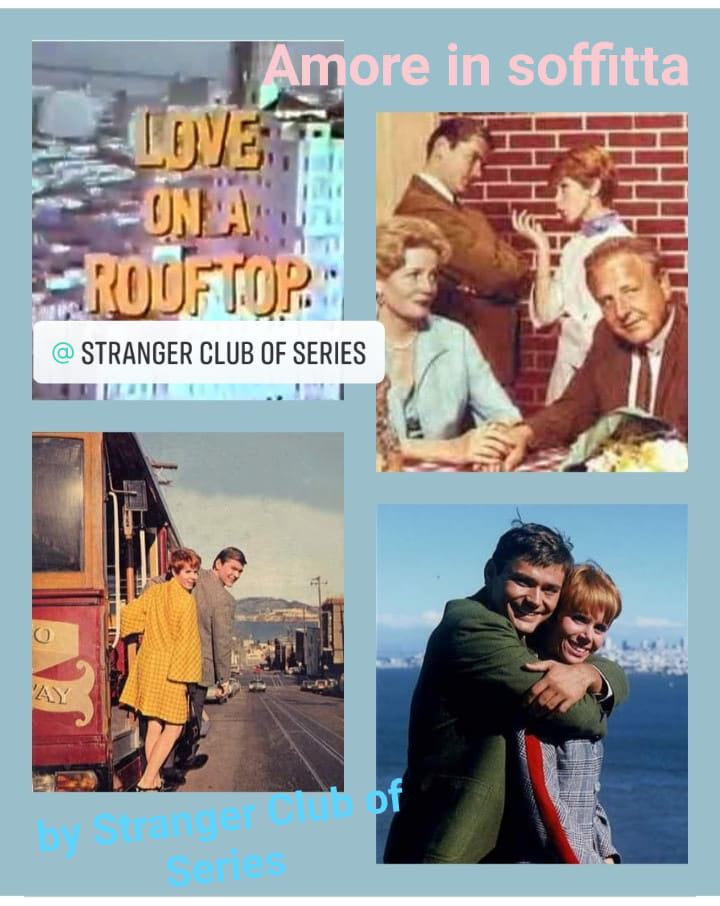Se torno un po’ indietro nel tempo vado a ripescare nella mia memoria uno dei miei anime preferiti, “Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare” (Hime-chan no ribbon, letteralmente “Il fiocco della piccola Hime”).
L’anime è tratto dall’omonimo shojo manga pubblicato tra il 1990 e il 1994 sulla rivista giapponese Ribon e vede come protagonista Himeko Nonohara, detta Himi, una tredicenne curiosa, piena di vita e un po’ maschiaccio, ma ricca di sogni che cura dentro di sé e non rivela a nessuno.
Un giorno qualcosa cambia nella vita di Himi: la ragazzina si imbatte in Erika, una sua coetanea che le somiglia parecchio, ma che viene addirittura dal regno della magia. Erika è la principessa del regno della magia e, per diventare regina e succedere a suo padre, deve inventare un oggetto magico da far collaudare ad una persona sulla Terra. Decide, quindi, di costruire un fiocco per capelli e di donarlo a Himi, la sua sosia terrestre; infatti ogni abitante del regno della magia ha un proprio sosia terrestre, per cui, dopo un’iniziale fase di incredulità, Himi accetta la richiesta di Erika e indossa il fiocco.
Il fiocco magico consente a chi lo indossa di trasformarsi nella persona che desidera, ma la trasformazione dura al massimo un’ora altrimenti la magia diventa irreversibile, per cui serve stare molto attenti.
Pian piano l’amicizia tra Himi ed Erika diventa sempre più costruttiva ed entrambe crescono imparando giorno per giorno dalla vita e dalla magia e anche da Pokotà, il leoncino di pezza di Himi che grazie al fiocco potrà parlare. Nel tempo Himi acquisirà altri poteri, la capacità di sdoppiarsi, grazie ad un astuccio magico, fermare il tempo, rimpicciolire e ingrandire oggetti o persone.
Himi presto dovrà condividere il suo segreto con Daichi Kobayashi, anche detto Dai-Dai, un suo coetaneo che inizia a sospettare di lei perché scopre una sua trasformazione. Da qui in poi l’amicizia tra Himi e Dai-Dai si trasformerà forse in qualcosa di più importante.
Cosa succederà quando terminerà l’anno di collaudo? Himi ed Erika non si vedranno mai più o Himi dovrà dimenticare tutto quello che è accaduto nel frattempo?
Un anime degno di rappresentare quelle storie che tanto ci sono piaciute negli anni Novanta. Le caratteristiche ci sono tutte: la magia, la fantasia, il percorso di crescita, i primi amori, l’aiutante magico e la speranza di realizzare un mondo migliore, come cantava Cristina D’Avena nella sigla di apertura.
“Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare” è un anime composto da 61 episodi e, se non lo avete mai visto, vi consiglio di recuperarlo anche solo per fare un tuffo nell’incanto e nella magia di una storia che fa bene al cuore e all’umore.
Memoru Grace