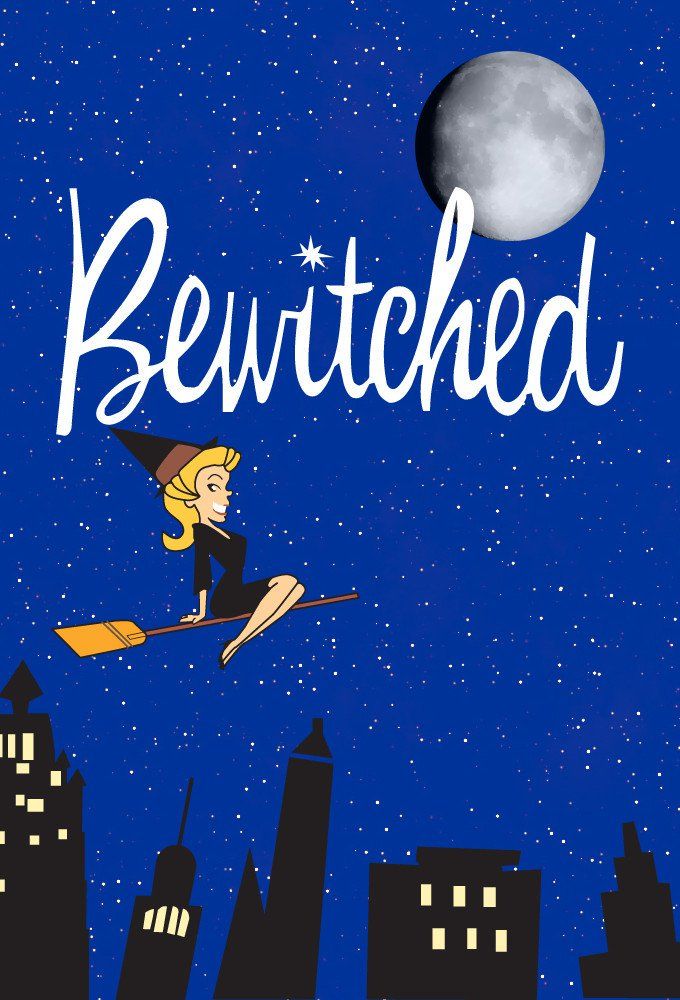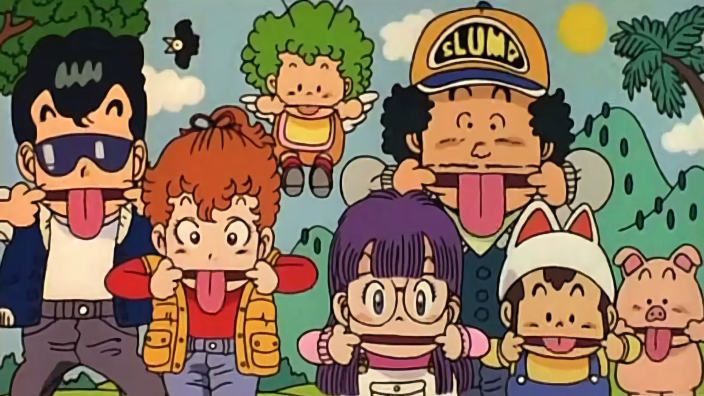“Il nostro futuro arriva con così tante diverse opzioni”.
Secondo qualsiasi dizionario, il termine “felicità” indica uno stato d’animo tipico di chi è sereno, non turbato da preoccupazioni diversificate e che, pertanto, può godere del suo stato d’animo, in una situazione di pieno appagamento e soddisfazione, producendo diversi sentimenti che vanno dalla gioia, alla lietezza, alla tranquilla pacatezza anche solo di un singolo momento. Ma il termine “felicità” è anche uno dei più usati e abusati al mondo: normative e costituzioni inseriscono, talvolta, la ricerca della felicità nel catalogo dei diritti da garantire all’individuo (“the pursuit of happiness” della Costituzione USA) e si attivano perché sia effettivamente raggiunta, identificandola, quindi, in un senso di benessere omnicomprensivo della parte materiale e di quella più immateriale, connessa allo stato mentale ed emotivo. E pare che di felicità visibile ce ne sia ben poca in questo drama horror/thriller dal titolo quasi antitetico, il primo a trattare veramente la pandemia da COVID-19, gravando la mano con l’invenzione di un’altra nuova (e più grave) epidemia, che mette in discussione ogni cosa, dal concetto di felicità nella sua materializzazione più estrema, al senso di umanità, per trasformare gli esseri umani in vere e proprie creature mostruose.
Yoon Sae-bom (Han Hyo-joo, la vera Action Queen già vista in Pirates e in W – Two Worlds Apart e qui al massimo del suo splendore, perché, diciamolo, tutte quante vorremmo essere come lei, belle, forti e coraggiose anche in tuta da ginnastica) è una giovane e risoluta agente della KP-SOU (l’unità speciale anti-terrorismo), che sta facendo velocemente carriera per le sue abilità. Un giorno, trova l’opportunità di acquistare a buon prezzo un appartamento in un complesso residenziale nuovo, ma, visto che le probabilità di accedervi aumentano se dimostra di essere pronta a formare una famiglia, con un privilegio per giovani nubendi, propone al migliore amico di sempre, il detective di polizia Jung Yi-hyun (Park Hyung-sik, il Re nascosto di Hwarang, visto anche in The Heirs, Soundtrack #1 e Relumino – Two Lights, che con questo drama ha sancito il ritorno dal suo periodo obbligatorio di leva), di sposarsi con un matrimonio di convenienza. I due, in realtà, si sono già conosciuti ai tempi del liceo, quando Yi-hyun, giovane promessa del baseball, aveva tentato di sfogare la sua frustrazione salendo sul tetto della scuola e Sae-bom, che tornava a frequentare le lezioni dopo una lunga malattia, salì decisa sul tetto per salvargli la vita, buttandolo giù o, meglio, dandogli il coraggio di buttarsi per affrontare davvero la vita. Sembra che nulla possa mettersi di traverso a questa giovane coppia di sposi, che sono troppo amici e troppo timidi per dichiarare il loro amore reciproco, ma che hanno una complicità intensa ed esclusiva. Se non fosse che Sae-bom, durante un’esercitazione, viene in contatto con un infetto di una nuova misteriosa epidemia e il suo capo, il colonnello Han Tae-seok (interpretato da Jo Woo-jin, il segretario plenipotenziario di tutto in Goblin, visto anche in NarcoSaints, qui straordinaria e fredda macchina da guerra paragonabile a Chishiya di Alice in Borderland e al Lee Eun-hyuk di Sweet Home), temendo per la sua incolumità, la costringe ad una quarantena. La nuova epidemia, infatti, sembra far perdere il senno alle persone che ne vengono contagiate, trasformandole in creature a metà tra gli zombie e i vampiri, desiderose di sangue umano e pronte a contagiare gli altri con un solo morso. Perlopiù, sembra che la nuova malattia sia causata dalla diffusione di un farmaco, dal nome futuristico Next, usato inizialmente come integratore per combattere diversi malesseri, compreso gli effetti della recente pandemia. Non siamo ancora usciti del tutto dal COVID-19, le persone vanno in giro indossando mascherine e si razionalizzano gli spazi negli ascensori. Sae-bom, dopo un periodo in ospedale, passa il resto del suo isolamento vigilato nella nuova casa e cerca di conoscere i vicini (personalmente, mai fare questo tentativo), che sono una massa informe di cattiveria e di ipocrisia e che qualificano la propria importanza a seconda del piano occupato e a seconda del costo dell’appartamento. In una vera e propria divisione della società, pari solo a quella de Il condominio di J.G. Ballard, ai piani alti si trovano gli appartamenti dei più ricchi, che impediscono a quelli dei piani bassi di usare uno dei due ascensori e gradiscono tenere chiusa la porta tra il quinto e il sesto piano per evitare massificazioni, così come vietano l’utilizzo di alcune strutture agli inquilini considerati più “poveri” (come la palestra e il campo da golf). Il caso vuole, però, che, a causa della scoperta di un infetto pericoloso nel condominio e del propagarsi della nuova malattia, la zona venga messa sotto un severo regime di lockdown e Sae-bom e Yi-hyun, accompagnato dal fidato collega Kim Jung-guk (Joon Hyuk-lee di Mystic Pop-up Bar), si trovino incastrati nel loro nuovo condominio a convivere a stretto giro sia con infetti in continuo aumento, che con i pericolosi e deliranti vicini, che, passo passo, perdono la sanità mentale peggio degli infetti. Forse anche perché “A volte, gli umani sono coraggiosi e, altre volte, sono codardi; gli esseri umani sono così ardui da capire“.
Avete presente quelle scene folli da saccheggio dei supermercati che ci sono rimaste impresse negli occhi? Ecco, con l’aggravante che, in questo caso, la logica del saccheggio non si ferma solo agli scaffali dei negozi, ma invade anche le abitazioni private di persone colpevoli di avere in casa più provviste di altri e, quindi, “costrette” a condividere. Il tutto condito da un blocco ad elettricità, acqua corrente e internet e da un cordone militare pronto a sparare nel caso di tentativi di fuga. Qui Happiness affonda le radici in una sferzante critica sociale e politica, da un lato, ai metodi di intervento per arginare la propagazione del contagio, ma anche alla sperimentazione scientifica e all’incuria farmaceutica e alle loro conseguenze negative, dall’altro, a come la società sprofonda nel baratro infernale dell’irragionevolezza e dell’inquietudine per una perfidia malevola interna, che fa rompere il meccanismo di controllo delle sovrastrutture.
La composita umanità dell’edificio è quanto di più inumano possibile e, in ciò, il drama si distingue molto da altre serie simili, che partono da uno spunto post-apocalittico e distopico per analizzare la società. A differenza di un drama come Sweet Home, infatti, dove di fronte a cattivi psicopatici e alla trasformazione in mostri, campeggiano figure positive grandiose, capaci di atti di eroismo senza accorgersene, qui, invece, si è dato più spazio alla degenerazione morale e alla grettezza umana in situazioni di crisi, avvicinando la narrativa più allo stridore sociale di Parasite. La signora Oh Yeon-ok (interpretata da Bae Hae-sun, la capostaff di Hotel Del Luna) è una paranoica stizzosa e schizofreinica, che, investitasi da sola dell’onere del comando di tutti, persegue i suoi obiettivi di gloria (diventare rappresentante dei condomini), anche passando sul cadavere altrui. Il dottore Oh Ju-hyung (Baek Hyun-jin di Taxi Driver) è la grettezza fatta persona, non riesce a trovare mai redenzione, anche perché non la cerca affatto (quanto siamo stati contenti quando Sae-bom gli ha assestato un calcio ben centrato in una determinata zona?), e non fa altro che tramare contro tutti. L’avvocato Kook Hae-seong (Park Hyun-soo di Crash Landing on You e Interest of Love) è meschino, viscido e pavido e pensa solo a due cose, tradire la moglie e fare soldi. Woo Sang-hee (Moon Ye-won di One Ordinary Day) è una donna arrivista e spregiudicata che usa solo il suo corpo per ottenere qualcosa e ha sempre sete di denaro. Kim Seung-beom (Joo Jong-hyuk di Avvocata Woo) è un simulatore mellifluo, che gioca nel fomentare le liti. Go Se-kyu (Kim Young-woong di Vincenzo) e Jo Ji-hee (Lee Ji-ha, apparsa anche in Eve e Squid Game) sono la coppia che gestisce l’impresa di pulizie e la cui avidità diventa presto una brama accentuata di accaparrarsi i beni e le case altrui (proprio come in Parasite). Tra tanti personaggi gretti, però, vorrei far risaltare il bel rapporto fratello-sorella costruito dal binomio Na Soo-min (il compianto Na Chul) e Na Hyun-kyung (Hee Von-park), che non sono perfetti e litigano e si azzuffano a vicenda, ma che, nel momento del bisogno, ci sono sempre l’uno per l’altra e che dimostrano un’umanità che manca a tutti gli altri. E, poi, c’è la piccola Park Seo-yoo (interpretata da Song Ji-woo, già apparsa come guest star in diversi drama e di cui prevediamo una luminosa carriera futura).
Riusciranno Sae-bom e Yi-hyun a sopravvivere all’epidemia, ma, soprattutto, riusciranno a sopravvivere alla degenerazione del genere umano, al di là di qualsiasi contagio virale? Potranno mantenere la propria umanità e l’onestà che li caratterizza, nonostante il mondo intorno cada a pezzi? Non aggiungo volutamente altro, perché ogni singolo frammento di questo drama va guardato con estrema attenzione, quasi come se fossero tante storie ad incastro, e perché ogni singolo passo va compiuto con estrema cautela, come in una formazione e in un’elevazione verso l’altro, mentre la narrazione ci propone una serie di quesiti morali che rimangono impressi a fuoco.
Anzitutto, che cos’è la felicità? E come si guadagna un sorriso che sembra un raggio di sole? Ma, soprattutto, è vero che dietro ogni sorriso è nascosto uno sprazzo di felicità oppure è vero il contrario? Quante volte cerchiamo la felicità, come una chimera, e persistiamo in ogni singolo secondo della nostra esistenza per afferrarla in un piccolo effimero momento, che, poi, si rivela essere solo uno stato di benessere più o meno transitorio, un appagamento momentaneo o uno sprazzo di soddisfazione. Dopo una lunga malattia o dopo un lungo periodo di grave stasi (come quello causato dalla pandemia di COVID-19), il primo augurio che viene fatto è “Sii felice“, quasi come se fosse necessario e obbligatorio raggiungere uno stato emotivo, della cui definizione non siamo nemmeno sicuri. Talvolta, confondiamo il concetto di felicità con quello che la società ci impone: si è felici quando si ha un lavoro stabile, una vita sentimentale certa, una vita sociale soddisfacente e una casa, un luogo di fissa dimora dove poter incidere il nostro io, quasi un marchio di valore nel mondo. Poi, ci troviamo ad avere tutte queste cose e non ci sentiamo ugualmente felici, come in corsa per avere sempre di più, per affermare la nostra impronta e, ove questo non risulta sufficiente, per avere quello che hanno gli altri, perché, se gli altri appaiono felici ai nostri occhi, anche solo per un frammento di nulla che pare illuminare il loro sguardo, allora lo bramiamo immediatamente e ce ne impossessiamo con una fame endemica come quella di mostruose creature. E, in tutto ciò, non abbiamo ancora compreso cos’è il vero concetto di felicità. Come la protagonista, anche noi tendiamo a cercare la felicità nello stato che viene imposto e condiviso, ma, alla fine, non ne siamo appagati e, solo quando stiamo per perdere ciò che ci è realmente caro, ne comprendiamo il suo valore e riusciamo a scioglierci, ma anche a lottare con le unghie e con i denti per mantenere i propri affetti. Allora, la felicità diventa semplicemente quel senso di limpida e pacata continuità di vivere vicino a chi si ama, senza porsi altri dubbi.
Happiness (해피니스) è un drama di genere fantasy/horror composto da 12 episodi, che ha ottenuto un consenso unanime da pubblico e critica, raggiungendo traguardi elevatissimi, ed è considerata una delle opere più riuscite nella narrativa da apocalisse zombie, di cui i sudcoreani sono maestri (Train to Busan, Alive). Come gli altri titoli dello stesso genere, usa l’espediente horror per introdurre una serie di argomenti critici sulle disparità sociali, sull’economia e sulla politica, applicabili sicuramente al contesto in patria (il possesso e la proprietà di una casa sono considerate in Corea del Sud un importante status di valutazione sociale), ma adattabili anche in altre realtà. A differenza degli altri titoli, però, ha osato sollevare un problema molto attuale, non solo ispirandosi, ma facendo chiaro riferimento alla situazione pandemica odierna per lanciare anche un messaggio di speranza per il futuro. In tutto ciò, la sceneggiatura riesce a mantenere un equilibrio raro tra colpi di scena, momenti di stasi, drammaticità, battute e scene più leggere, costruendo due (ma anche tre, perché io ho adorato il colonnello) personaggi principali che rimangono nel cuore anche per la loro empatia e la loro profondità d’animo.
Inoltre, introduce un concetto che forse spesso ci dimentichiamo, quello di non vivere la malattia come una colpa: “Non è un crimine essersi ammalati“, afferma più volte Yi-hyun per rammentare che dietro ogni maschera di malattia è celato un essere umano, che ha il diritto di essere protetto e curato, senza essere derubricato ad un semplice numero in un’agghiacciante statistica di morti e contagiati. La malattia è una linea sottile che percorre tutto il drama e non solo riferendosi alla scelta di raccontare lo scoppio di un’epidemia, ma come filo conduttore che ha infuso il superpotere della consapevolezza e, paradossalmente, della resistenza di fronte alla nuova epidemia: Sae-bom è stata malata durante la sua adolescenza, tanto da dover saltare degli anni di scuola per recuperare più avanti; la piccola Seo-yoo soffre di una malattia non meglio specificata che la costringe a non frequentare la scuola e a studiare da casa; la moglie del detective Kim Jung-guk, che rimane invisibile e muta per tutto il drama, se non nelle citazioni del marito, ha superato un cancro e lotta contro la possibilità della recidiva. Si tratta di una chiave di lettura particolare e interessante, quanto mai comprensibile in un periodo come quello che stiamo vivendo e che, fornita all’indomani della fine della pandemia, dovrebbe infondere una maggiore consapevolezza per affrontare il futuro e per apprezzare la vita in ogni singolo giorno che ci viene dato. Frammenti rari di felicità strappati lungo i bordi.
Pertanto, mi sento di concludere con le parole che sono state poste in epigrafe al drama: The world is a bit different from how it was before COVID-19, but thanks to that, we learned how precious an ordinary day can be. Smile when you see people’s faces without masks on and take a deep breath as you look up at the blue skies. I hope your afternoon is filled with happiness.
Consigliato: a chi ama il genere thriller/horror/fantasy post-apocalittico, epidemico e distopico, ma senza troppi e inutili bagni di sangue; a chi ama la coppia Han Hyo-joo e Park Hyung-sik sullo schermo (basta solo guardare due fotogrammi per capire quanto sono perfetti insieme); a chi cerca un drama diverso dal solito romance, ma che porti ad una profonda riflessione su innumerevoli argomenti; a chi ha compreso il valore di una singola giornata di sole in mezzo alle nubi del temporale.
Postilla: in aggiunta al drama, merita un recupero a sé anche la OST, che è un mix perfetto di pop, rock, techno, elettronica, indie, classica e synt e che contiene una meravigliosa canzone di Isaac Hong.
Captain-in-Freckles